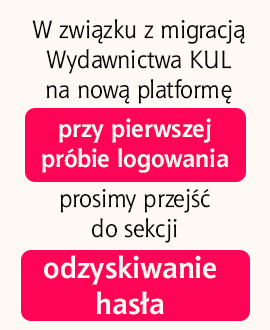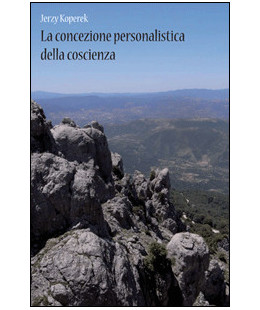La concezione personalistica della coscienza
Jerzy Koperek
ISBN: 978-83-7363-865-5
Stron: 352
Format: A5
Rok wydania: 2009
INDICE
INTRODUZIONE
CAPITOLO I
IL CONCETTO DELLA PERSONA UMANA IN KAROL WOJTYŁA
1. LA METODOLOGIA DEL PENSIERO FILOSOFICO DI KAROL WOJTYŁA
2. IL SISTEMA PERSONALISTICO DI KAROL WOJTYŁA
2.1. Il personalismo tomista
2.1.1. "Compositum humanum"
2.1.2. "Anima rationalis"
2.2. Il problema dell'esperienza e il metodo fenomenologico
2.2.1. L'esperienza umana e l'esperienza della moralità
2.2.2. Scientificità dell'etica e della filosofia
2.2.3. Razionalismo ed empirismo
2.3. La sintesi del tomismo e della fenomenologia
CAPITOLO II
LA NATURA DELLA COSCIENZA MORALE NEL PERSONALISMO DI KAROL WOJTYŁA
1. PERSONA E ATTO
1.1. Il legame tra l'antropologia e l'etica
1.2. L'atto e il suo valore morale che svela la persona
1.2.1. L'esperienza del fatto "l'uomo agisce"
1.2.2. La moralità come proprietà degli atti umani
1.2.3. "Induzione" e "riduzione" come metodo per esplorare l'esperienza del fatto che "l'uomo agisce"
2. L'UNITÀ DELLA PERSONA NELL'ATTO. L'UOMO COME "SUPPOSITUM"
2.1. La sintesi della soggettività e dell'operatività
2.2. Il soggetto dinamico o l'unicità dinamica
3. IL CONCETTO POSITIVO DELLA SPIRITUALITÀ E DELLA MORALITÀ UMANA
3.1. La trascendenza della persona nell'atto
3.1.1. La trascendenza orizzontale e verticale
3.1.2. L'unione dinamica tra la realtà morale e la spiritualità
3.1.2.1. L'interiorità sperimentale
3.1.2.2. L'autodeterminazione
3.1.2.3. "Natura" e "persona" nel contesto della morale
3.1.2.4. L'elemento spirituale e morale spiegato nel concetto dell'unità della persona nell'atto
3.1.2.5. La dinamicità e la potenzialità spirituale dell'uomo
3.1.2.6. Il valore dello studio "Persona e atto"
3.1.2.7. Il carattere trascendente della persona umana
3.2. L'integrazione della persona nell'atto
3.2.1. La soggettività come campo in cui si manifesta l'integrazione della persona nell'atto
3.2.2. La personalità morale e la psiche umana
3.2.3. La coscienza morale e l'operatività
CAPITOLO III
IL SIGNIFICATO DELL ASPETTO CONOSCITIVO NELLA NORMATIVITÀ DELLA COSCIENZA MORALE
1. LA FUNZIONE DIRETTIVA DELLA COSCIENZA MORALE
1.1. La coscienza morale connessa con l'intelletto attraverso la consapevolezza
1.1.1. "Azione cosciente" e "coscienza dell'azione"
1.1.2. La coscienza come contenuto soggettivo dell'esistenza e dell'azione dell'uomo
1.1.3. La funzione riflessiva come l'elemento oggettivo-razionale della coscienza
1.1.4. La coscienza morale e la consapevolezza
1.2. La coscienza morale connessa con l'intelletto attraverso la verità
1.2.1. "Appetitus rationalis"
1.2.2. Gli atti intenzionali: "pensare" e "volere"
1.2.3. La dipendenza dell'autocoscienza morale dalla verità
1.2.4. La subordinazione dell'intelletto alla verità che condiziona la trascendenza della persona
2. LA FUNZIONE GIUDICATIVA DELLA COSCIENZA MORALE
2.1. La verità sul bene come principio oggettivo permette alla coscienza morale - alla "praxis" - di distinguere il bene dal male
2.1.1. La ricerca della verità e la certezza dei giudizi morali
2.1.2. La morale come realtà comprensiva
2.1.3. La decisione come risultato del giudizio pratico dell'intelletto
2.1.4. Il condizionamento della volontà da parte della conoscenza
2.1.5. La conoscenza dei valori come base di formulazione dei giudizi morali
2.1.6. La verità assiologica
2.1.7. "Bonum honestum – utile - delectabile"
2.2. Formulare i giudizi
2.2.1. "Agere" e "pati"
2.2.2. "Conosco" e "penso"
2.2.3. Il giudizio corne manifestazione del dinamismo conoscitivo dell'uomo sulla base del momento della verità
2.2.4. Il momento della verità e la corrispondenza tra il giudizio e la decisione
2.2.5. L'intuizione conoscitiva nel riferimento all'esperienza vissuta dei valori
2.2.6. Il momento della verità nel processo conoscitivo: discorsivo e giudicativo
CAPITOLO IV
LA PARTECIPAZIONE DELLA LIBERA VOLONTÀ ALLA NORMATIVITÀ DELLA COSCIENZA MORALE
1. LA COOPERAZIONE TRA LA VOLONTÀ E LA RAGIONE
1.1.1 presupposti di David Hume
1.2.1 presupposti di Immanuel Kant
2. LA LIBERTÀ UMANA NEL RIFERIRSI ALLA NORMA DELLA MORALITÀ COME FONTE DI DIVENIRE DELL'UOMO MORALMENTE BUONO O CATTIVO
2.1. Dinamismo e "fieri" del soggetto umano
2.1.1. Dinamismo del soggetto umano
2.1.2. Fieri dell'uomo nel suo agire morale
2.2. La libertà e la normatività della coscienza morale
2.2.1. La libertà come radice della morale umana
2.2.2. La libertà e la norma morale
3. IL SIGNIFICATO DELLA VOLONTÀ NELLAUTODETERMINARSI BUONO O CATTIVO MORALMENTE
3.1. L'autodeterminazione come relazione della persona con la libera volontà
3.1.1. L'autodeterminazione e la norma morale
3.1.2. L'autodeterminazione condizionata dall'auto possesso e dall'autodominio
3.2. La persona come suppositum rivelato attraverso l'autodeterminazione
3.2.1. Ogni voglio come fatto soggettivo di autodeterminarsi buono o cattivo ....
3.2.2. La libera volontà manifestata come autodeterminazione
4. LA VERITÀ SUL BENE COME NORMA DELLA COSCIENZA MORALE A CUI SI RIFERISCE LA LIBERA VOLONTÀ
4.1. La libertà della volontà nello scegliere il vero bene
4.1.1. Il rapporto della volontà con la verità sul bene
4.1.2. La disposizione dinamica della persona nel tendere al bene concreto
4.1.3. La libera scelta nel contesto della discussione dei motivi
4.1.4. La scelta autonoma dell'oggetto come manifestazione della libertà contro il determinismo
4.1.4.1. Il determinismo come annullamento della libertà
4.1.4.2. Il condizionamento della volontà attraverso una motivazione, ossia una presentazione dell'oggetto
4.1.4.3. L'indipendenza dell'uomo rispetto agli oggetti e ai valori
4.2. La dipendenza degli atti dalla verità sul bene, ovvero dalla norma della coscienza morale
4.2.1. Il riferimento alla verità come ragione essenziale della scelta
4.2.2. La verità sul bene come norma morale
4.2.3. La realizzazione della persona attraverso l'atto
4.2.4. Il dinamismo spirituale della persona determinato dalla dipendenza della volontà dalla verità
CAPITOLO V
IL DOVERE COME POTERE NORMATIVO DELLA VERITÀ CONTENUTO NELL AUTOCOSCIENZA MORALE
1. DEONTOLOGIA NELL'ETICA DI TOMMASO D'AQUINO E DI MAX SCHELER
1.1. Il bene oggettivo secondo Tommaso d'Aquino
1.2. La filosofia dei valori secondo Max Scheler
1.3. L'apertura alle tendenze filosofiche moderne
2. L'UNIONE TRA IL VERO E IL DOVERE ALLA BASE DEL POTERE NORMATIVO DELL'AUTOCOSCIENZA MORALE
2.1. La trascendenza della verità e della morale
2.1.1. Il legame tra la libertà e il dovere
2.1.2. La dipendenza dell'autocoscienza dalla verità sul bene come realtà normativa
2.1.3. Il dovere come specifica esperienza vissuta radicata nel valore
2.1.4. L'unione tra il vero e il dovere alla base del potere normativo dell'autocoscienza morale
2.2. La norma e il dovere
2.2.1. Valori morali e norme
2.2.2. Il dovere come l'elemento costitutivo della morale
2.2.3. Le norme della coscienza e il dinamismo della persona
3. LA REALIZZAZIONE DI SÉ ATTRAVERSO IL COMPIMENTO DEL DOVERE
3.1. La realizzazione di sé e il vero
3.1.1. La realizzazione dinamica di sé e l'autodeterminazione
3.1.2. Il dovere come l'obbligo sociale e l'elemento integrale del compimento dell'atto
3.1.3. La correlazione tra la coscienza come fonte interpersonale del dovere e l'ordine oggettivo delle norme morali
3.2. Il carattere creativo dell'autocoscienza e la realizzazione di sé 224
3.2.1. La certezza soggettiva del bene e l'obbligo
3.2.2. L'obbedienza e la norma
3.2.3. L'equilibrio ontico ed etico della persona contro l'individualismo
3.2.4. La creatività della coscienza ed i principi oggettivi
3.3. La realizzazione di sé sulla base del legame tra il dovere e la volontà nella verità
3.3.1. La libertà e il dovere come potere normativo della verità
3.3.2. Il passaggio dal valore al dovere e la vocazione a realizzarsi negli atti
3.3.3. Il dramma dei valori nella realizzazione di sé
3.3.4. L'apertura della persona ai valori nel dovere
4. RELAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CON IL DOVERE COME POTERE NORMATIVO DELLA VERITÀ
4.1. Il dovere nella relazione tra la responsabilità e l'operatività
4.1.1. La responsabilità dell'uomo come autore dell'atto
4.1.2. La relazione: rispondenza ai valori - responsabilità
4.2. La responsabilità morale del soggetto
4.2.1. La responsabilità dei valori
4.2.2. La responsabilità e l'autorealizzazione delP"io" personale in ogni atto
4.2.3. La responsabilità e l'autorità della persona nella sua coscienza
4.2.4. La responsabilità nei riguardi degli altri
4.2.5. La responsabilità intimamente legata all'agire dell'uomo
CAPITOLO VI
L'APPORTO DI KAROL WOJTYŁA AGLI STUDI TOMISTICI
1. FILOSOFIA DELLA PRASSI COME RISULTATO DELL'ITINERARIO INTELLETTUALEDI KAROL WOJTYŁA
1.1. L'analisi dell'azione nella filosofia moderna
1.1.1. L'ispirazione del Concilio Vaticano II
1.1.2. Tomismo esistenziale
1.2. L'influsso dei filosofi moderni
1.2.1. Fenomenologia
1.2.2. Filosofia dell'uomo
2. IL CONCETTO DELLA "VERA" ANTROPOLOGIA SULL'ESEMPIO DELLA DISCUSSIONE SU "PERSONA E ATTO" ...
2.1. Lo sfondo storico di "Persona e atto"
2.2. Alcuni cambiamenti in "Persona e atto"
2.3. 2.3.1 concetti della discussione
2.3.1. L'accento sulla persona come soggetto della morale
2.3.2. La critica linguistica
2.3.3. Fenomenologia tomistica
2.3.4. L'uomo dato nell'esperienza
2.3.5. L'epistemologia
2.3.6. L'antropologia filosofica e l'esperienza vissuta dell'uomo
2.3.7. La sintesi fenomenologico-tomistica: induzione e riduzione
2.3.8. Il carattere trascendente della persona umana nella verità
2.3.9. Il significato pastorale
2.4. La densistà della problematica antropologica
3. L'APPORTO DEL PERSONALISMO DI KAROL WOJTYŁA ALL'ETICA CRISTIANA
3.1.1 diversi modi di presentare la problematica morale
3.2. La possibilità autentica di costruire l'etica cristiana
3.2.1. Il linguaggio filosofico di K. Wojtyla
3.2.2. Il concetto perfezioristico dell'etica cristiana
4. LE BASI DELLO SVILUPPO ULTERIORE DEL PENSIERO PERSONALISTICO-ETICO DI KAROL WOJTYŁA
4.1. L'integrità del pensiero personalistico di K. Wojtyla
4.1.1. Il legame tra filosofia e teologia
4.1.2. La continuità del pensiero personalistico di K. Wojtyla da filosofo e Papa
4.2. Il concetto della coscienza morale secondo la dimensione della persona umana
4.2.1.1 dettami della coscienza
4.2.2. La libertà nella verità come momento culminante della formazione morale
4.2.3. Il sacrificio del "rationale obsequium"
4.2.4. La formazione della coscienza morale secondo la verità antropologica
4.2.5. La legge della gradualità e la gradualità della legge
4.2.6. La norma sociale e personale
4.2.7. La formazione delle virtù
4.2.8. Gli elementi soggettivi dell'ordine etico
4.3. La coscienza morale come incontro della persona e dell'atto nel personalismo di K. Wojtyla
4.3.1. L'uomo-soggetto dell'agire al centro del personalismo
4.3.2. La ricerca della verità interiore nella coscienza morale
4.3.3. La prospettiva realistica dell'antropologia e della moralità umana
CONCLUSIONE
BIBLIOGRAFIA
I. FONTI
A. LE OPERE DI KAROL WOJTYŁA
B. L'INSEGNAMENTO DI GIOVANNI PAOLO II
C. DOCUMENTI DEL MAGISTERO DELLA CHIESA
II. LETTERATURA